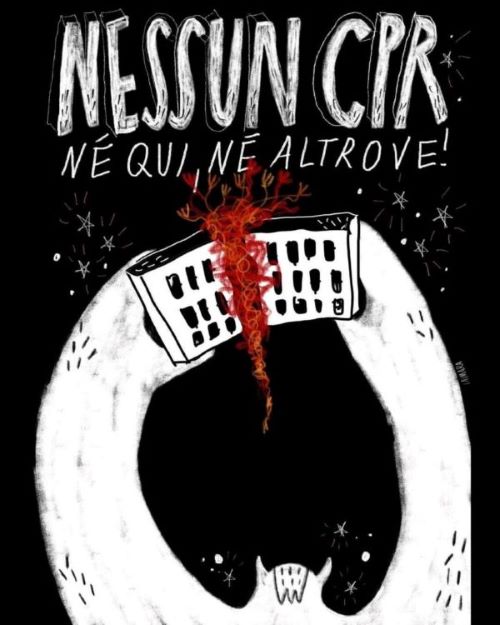La reclusione degli stranieri nei Centri di permanenza per il rimpatrio continua a sollevare gravi questioni di compatibilità con la Costituzione, da ultimo tornate all’attenzione della Corte costituzionale nella sentenza n. 96 del 2025 pubblicata nei giorni scorsi.
Alla base di tutto – è bene evidenziarlo – vi è una deficienza dello Stato, consistente nell’incapacità di provvedere, in tempi ragionevoli, all’accompagnamento alla frontiera degli stranieri privi di regolare titolo di soggiorno. La reclusione nei Cpr viene di conseguenza, e dovrebbe avere minima durata: lo stretto tempo necessario a effettuare l’espulsione. Invece, può protrarsi sino a 18 mesi e, in più nella metà dei casi, si conclude con il rilascio in libertà dello straniero, contestualmente invitato a rientrare nello Stato di provenienza con i propri mezzi: vale a dire, a riuscire là dove lo Stato ha fallito.
Le ragioni per dubitare della compatibilità con la Costituzione della normativa in materia sono molte: su tutte, il fatto che, non essendo il soggiorno irregolare un reato ma una condizione, le persone si ritrovano private della propria libertà personale – il “bene” costituzionale più prezioso, dopo la vita – non per ciò che hanno fatto, ma per quello che sono. Un esito difficilmente riconducibile ai principi dello Stato liberale di diritto, ma che una discutibile sentenza della Corte costituzionale – la n. 105 del 2001 – non ha ritenuto di sanzionare, pur riconoscendo la necessità di applicare, anche alla reclusione nei Cpr, le rigorose garanzie previste dall’art. 13 Costituzione: vale a dire, che sia la legge a disciplinare in via generale e astratta i casi e i modi in cui le persone saranno private della libertà (riserva di legge) e che sia un giudice a disporre la privazione della libertà nei casi particolari e concreti (riserva di giurisdizione).
Se già la riserva di giurisdizione è stata soddisfatta in modo discutibile, affidando la competenza a un magistrato onorario, e non di carriera, come il giudice di pace, ancor più problematico risulta il rispetto della riserva di legge, dal momento che il Parlamento ha adempiuto solo in parte ai propri doveri, disciplinando con legge i casi, ma non i modi della reclusione degli stranieri. La restante normativa è stata rimessa ai regolamenti governativi e ai provvedimenti amministrativi dei prefetti (questi ultimi differenziati sul territorio), con il risultato che le concrete modalità di detenzione nei Cpr (standard abitativi, servizi da erogare, rapporti con l’esterno ecc.) sono stabilite non in esito al confronto parlamentare democratico tra la maggioranza e le opposizioni, ma in forza di decisioni assunte dal medesimo organo che, tramite le forze di pubblica sicurezza, esegue la limitazione della libertà personale degli stranieri. Insomma: là dove la Costituzione prevede che la legge parlamentare operi come strumento di controllo dell’azione governativa è, invece, il Governo a darsi da sé medesimo le regole del proprio agire.
Chiamata a pronunciarsi su tale inadempienza parlamentare, con la recente sentenza la Corte costituzionale ha, sì, riconosciuto la violazione dell’art. 13 Costituzione, per via delle carenze della legge, ma ha altresì rinunciato a intervenire per porre rimedio, affermando che spetta al legislatore provvedere a colmare la lacuna. Dimenticando che, in passato, non di rado il legislatore ha evitato di dar seguito a moniti ben più incisivi (basi pensare al caso dell’eutanasia) e, soprattutto, che la Corte stessa ha a disposizione lo strumento delle decisioni “additive”: quelle con cui, in vista dell’intervento del legislatore volto a colmare la lacuna, sono indicati i principi costituzionali da seguire o, ancora più incisivamente, specifiche norme già esistenti nell’ordinamento da assumere temporaneamente a modello.
Con logica inusualmente contorta, la sentenza n. 96 del 2025 individua la possibilità di prendere a modello l’ordinamento penitenziario, ma subito la esclude, affermando che la detenzione nei Cpr, non essendo conseguenza della commissione di reati, deve «restare estranea a ogni connotazione di carattere sanzionatorio»: con il risultato che la posizione che meno giustifica la limitazione della libertà personale (la detenzione in seguito a un illecito amministrativo) si ritrova disciplinata in modo svantaggiato rispetto alla posizione che più la giustifica (la detenzione in seguito a un illecito penale). Un esito gravemente irragionevole, che rivela la persistente inadeguatezza della tutela costituzionale in materia di tutela degli stranieri e, più in generale, la difficoltà degli organi di controllo di operare con efficacia a tutela della Costituzione in un momento in cui i suoi principi fondamentali si ritrovano, come mai prima d’ora, sotto l’attacco del potere politico.
Francesco Pallante, Comune.it, 7/7/2025