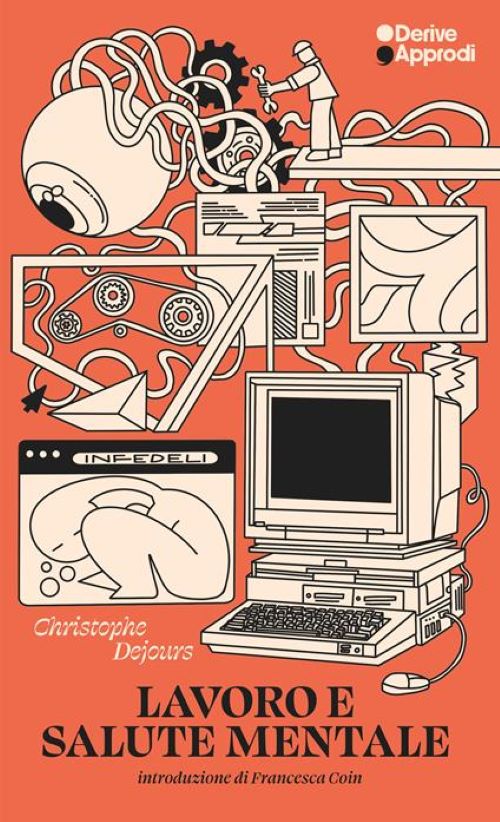Lavoro e salute mentale dello psichiatra, psicoanalista e medico del lavoro francese Christophe Dejours, tradotto da Vincenzo Di Mino e introdotto da Francesca Coin per DeriveApprodi (pp. 283, euro 22), è uno di quei libri che possono essere usati come una cassetta degli attrezzi necessari per trasformare la condizione sofferente di chi lavora e tornare a praticare una «strategia di emancipazione».
Pubblicato nel 1980 in Francia, il libro (che inaugura «Infedeli», la collana sulle trasformazioni del lavoro contemporaneo, diretta da Francesca Coin) ha avuto quattro edizioni ed è stato aggiornato, man mano che Dejours ha condotto importanti inchieste, che sono anche grandi libri filosofici, sulle trasformazioni dell’organizzazione capitalistica del lavoro e il suo rapporto contraddittorio con la soggettività di chi lavora nelle fabbriche e negli uffici, sia da dipendenti che da autonomi, uomini e donne. Nel corso di più di quattro decenni di ricerca Dejours ha sviluppato un pensiero originale, incentrato sulla «psicodinamica del lavoro».
Non si tratta di un’ergonomia che rende più produttivi i lavoratori, né solo di una «psicopatologia» che critica gli effetti dell’alienazione subita e praticata. È complesso definire l’autonomia di questa «scienza». Non è solo un sapere «tecnico» che evita gli infortuni o le morti sul lavoro. Non è solo una psicologia che cura i traumi dell’individuo, né solo un’analisi della psiche nella relazione tra sé e il mondo.
È appassionante il modo in cui Dejours ha narrato la nascita di questo «sapere minore» al servizio del movimento operaio. Tutto nasce dalla «presa di parola» degli operai sulla propria condizione psicofisica. Dopo il 1968, grazie anche ai movimenti sociali, la psicodinamica del lavoro è diventata un sapere critico a disposizione di tutti i lavoratori.
Dagli anni ’80 l’organizzazione del lavoro si è radicata anche nei processi della riproduzione sociale, non solo in quelli della produzione industriale manifatturiera avanzata, in quella tecnologica o nella logistica. Non c’è solo lo sfruttamento della forza fisica, ma anche quello della forza mentale. Non c’è solo la sofferenza intesa come «malattia mentale», ma anche quella intesa come «sindrome soggettiva post-traumatica» o «sindrome post-traumatica da stress».
Queste «sindromi» dipendono dall’organizzazione del lavoro e dalla storia socioprofessionale e socioaffettiva delle persone. Sono cresciute mentre la produzione ha messo al lavoro il soggetto anche al di là del luogo del lavoro. Tutte le passioni sono state messe al servizio della produzione della sofferenza. Non solo la resistenza ai traumi è un modo per aumentare il rendimento, questo era già chiaro dall’organizzazione taylorista della fabbrica. Oggi è anche dal modo in cui si resiste alla sofferenza, distruggendo la salute, che il capitale trae un profitto.
Il libro di Dejours è una genealogia della produttività delle passioni tristi: vergogna, ansia e, soprattutto, la paura. Dejours descrive le diverse «strategie di difesa» che spingono gli operai edili e chimici, le centraliniste fino ai piloti di caccia a «normalizzare» l’alienazione e a rendere produttive nevrosi, psicosi, stigmi e paure sociali. Sta qui, in fondo, l’«ambivalenza» del lavoro, e della sua alienazione, spesso confusa con la mera «reificazione». Un lavoro alienato può distruggere una vita, ma è pur sempre attraverso un lavoro – a cominciare da quello su se stessi nella cooperazione con gli altri – che ci si può liberare dal lavoro-merce.
Per capire l’importanza dell’impianto analitico e pratico della ricerca di Dejours, e la sua rilevanza in un’epoca in cui al lavoro è stata negata la politica, la storia e l’immaginazione, basti qui solo ricordare il ruolo influente esercitato dalle sue consulenze nel processo contro il «management del terrore» in France Télécom, un «mobbing» che ha portato 19 dipendenti al suicidio tra il 2007 e il 2008. «Il suicidio sul lavoro – ha detto Dejours – è la punta dell’iceberg. È un indicatore della distruzione del mondo sociale. Non è una fatalità perché l’organizzazione del lavoro è fatta da decisioni umane».
Lavoro e salute mentale, e altri libri scritti da Dejours come Si può scegliere, soffrire al lavoro non è una fatalità (Moretti & Vitali) o il capolavoro Lavoro vivo (Mimesis), permettono di decostruire la soggettività capitalistica e spiegano le ragioni per cui è molto difficile staccarla dal godimento distruttivo della propria sofferenza. Il lavoro, e la sua organizzazione, non sono solo un problema individuale, contrattuale, tecnico o psicologico. Sono un problema politico. Ci si può emancipare dalla sofferenza mentale che è l’esito di processi storici e concreti. Per farlo bisogna creare un’azione collettiva capace di mettere il lavoro al servizio della solidarietà e della trasformazione sociale, liberandolo dalla desolazione e dalla tossicità in cui è stritolato.
Roberto Ciccarelli, il manifesto, 21 ottobre 2025