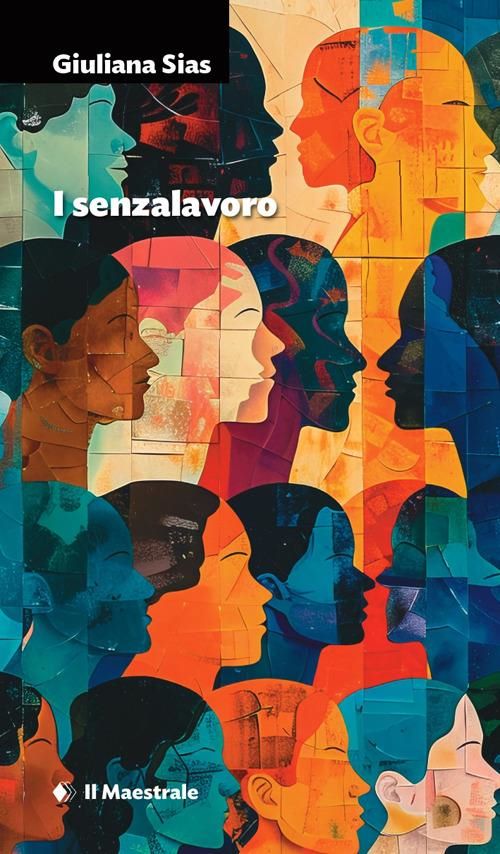Un inferno dal quale, se possibile, fuggire. Un numero sempre maggiore di persone lascia il lavoro oppure ad esso resiste passivamente. «Grandi dimissioni» è la definizione, ormai entrata nell’uso corrente, utilizzata per la prima volta da Anthony Klotz, docente alla Texas A&M University, per dare un nome all’esodo dei quarantotto milioni di persone che nel 2021, negli Usa, hanno abbandonato volontariamente il lavoro, un dato superiore di sei milioni rispetto al precedente record del 2019.
Nel 2022, poi, un nuovo picco, con cinquanta milioni e mezzo di americani che hanno preferito dire di no. E non sembra sia un fenomeno passeggero. Le analisi più recenti parlano di una tendenza di lungo periodo. Ma c’è di più: anche quando dal lavoro non si fugge, nei suoi confronti si assume un atteggiamento di distacco. Si chiama quiet quitting: si fa solo lo stretto necessario. In Cina, ad esempio, contro il «996», il sistema che richiede di lavorare dalle nove del mattino alle nove di sera per sei giorni alla settimana, è nato un movimento spontaneo che ha preso il nome di Tang Ping («sdraiarsi»): al superlavoro la risposta è sdraiarsi, appunto. Sabotare, fare resistenza passiva. E non è solo in Cina e in Usa che le cose vanno così. È uguale in tutte le società industriali avanzate, Italia compresa. Il lavoro, in definitiva, viene espulso dal novero delle motivazioni fondanti dell’esperienza di vita. Con la conseguenza che senza lavoro non sono solo quelli che non ce l’hanno perché lo cercano e non lo trovano. E neppure solo quelli che lo avevano ma lo hanno perso. Senza lavoro siamo tutti. Il lavoro è sempre di più un’assenza, un buco nero esistenziale.
Intorno a questo nodo ruota I senzalavoro, esordio narrativo di Giuliana Sias appena edito da Il Maestrale (pp. 240, euro 20). Protagonista è Vittoria, che il giorno del suo quarantesimo compleanno viene licenziata, senza uno straccio di motivazione, con un messaggio Whatsapp. Per lei, che nel lavoro aveva investito molto in termini di senso della propria esistenza, è un colpo duro. Per reagire impiega le giornate, diventate vuote, a pedinare di nascosto, per strada, persone sconosciute. Entra così nelle vite di tanti che, nella Milano degli anni Venti, il lavoro lo vivono come un incubo.
Luca, che viene sbattuto fuori dalla propria azienda perché ha denunciato pratiche illecite dei capi; Viola, licenziata dopo una maternità; Beatrice, psicologa di vaglia che, cedendo all’onda che ha fatto della psicoterapia una pratica commerciale, trasloca dallo studio professionale a Instagram, diventa una influencer di successo e paga tutto ciò con la dipendenza dall’alcol; Sole, che colpita da un tumore terminale non rivela la malattia per non essere messa fuori, va in aspettativa e muore di nascosto in una clinica svizzera; Silvia, altra star dei social che si suicida perché non regge più lo stress della gestione quotidiana dei «mi piace»; Alberto, broker con un conto in banca stratosferico che decide di mollare tutto perché Vittoria, rifiutandosi di stare con lui, destabilizza un trend di vita chiuso in un inscalfibile narcisismo.
Nel racconto che ne fa Sias, il lavoro è polverizzato in una serie infinita di microstorie di infelicità individuale, ognuna blindata in se stessa. In un universo in cui il dominio dei social annulla ogni pratica autentica di interazione, sono storie che mai vengono condivise. A conoscerle Vittoria ci arriva per caso. E scopre che «se nemmeno un contratto può assicurarti che alla fine del mese riuscirai a pagare un affitto e se non puoi nemmeno contare sul fatto che sapranno comunicarti in una maniera per te dignitosa il tuo licenziamento, significa che, pur lavorando, un lavoro non lo avevi nemmeno prima».
Tutti, dunque, siamo diventati dei senza lavoro, ma non è detto, si accorge Vittoria alla fine, che sia un fatto solo negativo. Dalla coscienza che lavorare non offre alla vita alcuna possibilità e che invece il lavoro la vita la annienta, può nascere oltre che il bisogno individuale di fuggire o di sottrarsi anche la determinazione a cambiare radicalmente lo stato delle cose – un ordine economico e sociale – dal quale il lavoro come esperienza nullificante viene generato.
Costantino Cossu, il manifesto, 21 agosto 2025