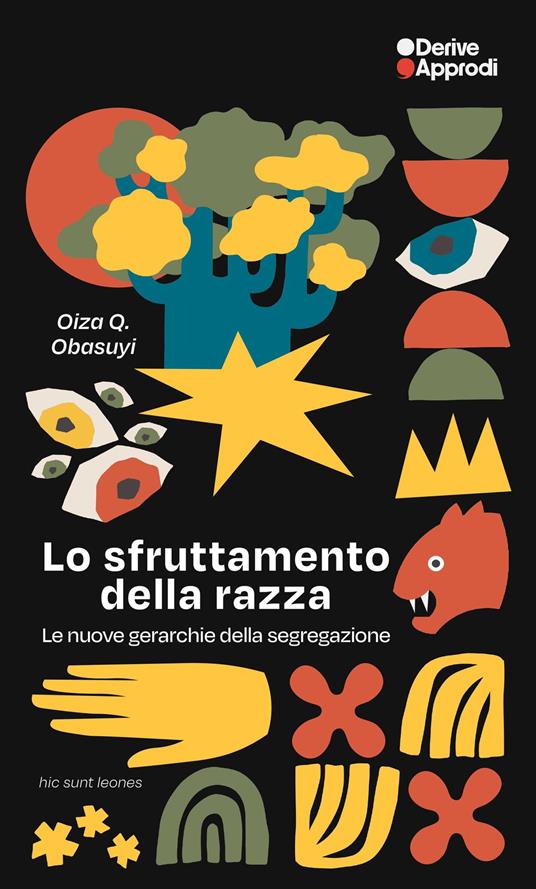Chi di noi si definirebbe razzista? Di sicuro in pochi, se si escludono i convinti estremisti di destra che fanno ancora oggi delle discriminazioni su base etnica il loro credo. Ben altra cosa è il razzismo introiettato, a livello dei singoli ma anche collettivo, attraverso la secolare percezione di superiorità rispetto al resto del mondo, che affonda le proprie radici nel colonialismo e nello schiavismo. Oggi quel percorso si è in parte invertito, e la migrazione sta contaminando in positivo una società come la nostra che tradizionalmente si interroga su molti temi – dalle libertà civili al senso della guerra -, ma raramente esce dalla compattezza del proprio sguardo «bianco».
È da questo punto di vista alternativo che prende le mosse Lo sfruttamento della razza. Le nuove gerarchie della segregazione di Oiza Q. Obasuyi (DeriveApprodi, pp. 143, euro 16). L’autrice, lei stessa giovane italiana afrodiscendente e attivista, ha il merito di accendere un faro intorno a un dibattito per noi ancora iniziale, anche se più sviluppato in paesi europei a più forte immigrazione, nato negli Usa delle lotte storiche della liberazione nera negli anni ’70 e ’80, che arriva fino al movimento Black Lives Matter.
Per spiegare la necessità di combattere il razzismo in cui siamo immersi, l’autrice si basa su una solida impalcatura teorica. Rimonta all’opera seminale del sociologo americano Cedric Robinson, che nel suo Black Marxism (1983) ha legato indissolubilmente capitalismo e razzismo come marchio della civiltà occidentale.
Lungo questa linea incontra poi la riflessione di Angela Davis, icona del femminismo antirazzista americano, che negli stessi anni ha indicato la persistenza delle discriminazioni verso le persone definite «razzializzate» (cioè quelle che vengono inquadrate attraverso la «razza» come costruzione sociale) anche all’interno delle democrazie liberali.
Partendo da queste premesse, Obasuyi sostiene che il suprematismo esplicito di vecchi e nuovi fascismi, non si può combattere senza analizzarne le radici nella tradizione europea: quella di inscrivere i diritti universali in convenzioni e costituzioni, assolvendosi così dal dovere di applicarle. Ma l’ostacolo maggiore al superamento delle discriminazioni risulta essere quello che l’autrice racchiude nel concetto di «razzismo istituzionale».
Quest’ultimo può essere esemplificato da un caso tragico, tra i tanti elencati nell’ampia parte del saggio dedicata alla situazione italiana – definita senza mezzi termini «desolante». Moussa Balde, migrante 22enne guineano, viene aggredito per strada nel 2021 a Ventimiglia, dove era arrivato superando il confine francese. Lo Stato non persegue chi lo ha assalito senza ragione (si tratta di tre italiani), mentre è proprio il migrante a dover pagare per il reato di clandestinità, una delle tante forme con cui viene sistematicamente criminalizzata l’immigrazione. Rinchiuso nel Cpr di Torino, il ragazzo si toglierà la vita pochi giorni dopo.
Leggi e decreti dello Stato vanno dunque nella direzione dell’espulsione dalla società, tanto da far percepire i migranti come un corpo estraneo. In questo consiste l’aspetto istituzionale della discriminazione: «Nessuno governo», neppure di sinistra, sottolinea l’autrice, «ha abrogato le norme che imprigionano (…) stranieri e straniere (…) nelle maglie della segregazione».
Di questo razzismo – che potremmo definire più voluto per convenienza politica che dettato dalla paura – Obasuyi passa in rassegna le mille sfumature. Il lettore ripercorrerà tutte le ingiustizie di Stato nei confronti delle persone razzializzate nel campo dell’immigrazione e della mancanza di libertà di movimento, del lavoro e del diritto negato alla cittadinanza. Le donne risultano doppiamente svantaggiate in questa triste casistica e l’Italia svetta in negativo, perfino all’interno della «Fortezza Europa», con Meloni leader delle pratiche discriminatorie (si veda il modello Albania).
Una cosa è certa: il tema affrontato in questo saggio riguarda da vicino la maggioranza non razzializzata della popolazione. C’è da chiedersi come si possa ancora parlare di democrazia in senso pieno di fronte a forme di segregazione conclamate
Andrea Valdambrini, il manifesto, 13 agosto 2025