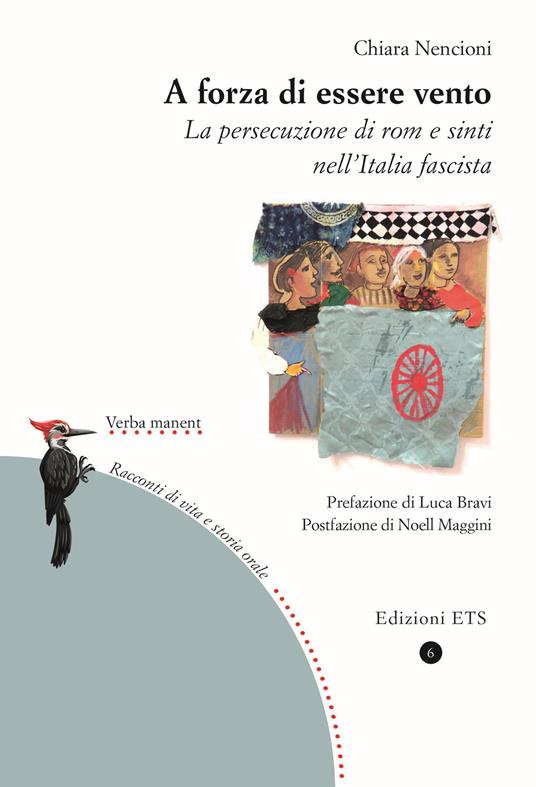Qui di seguito la recensione, apparsa su il manifesto, di un libro importante perché ci racconta una storia dimenticata: un “porrajmos” (grande divoramento) o meglio un “samudaripen” (sterminio di tutti, ovvero genocidio), come preferisce chiamarlo l’autrice, Chiara Nencioni, A forza di essere vento racconta la persecuzione e lo sterminio dei rom e dei sinti nell’Italia fascista.
*****************************************
Il ricordo di un passato condiviso, ossia ciò che chiamiamo memoria collettiva, è un concetto elaborato negli anni ’20 dello scorso secolo da Maurice Halbwachs, sociologo francese morto deportato a Buchenwald nel ’45. Questo sistema di ricordi condivisi può esistere solo in riferimento a coordinate spazio-temporali determinate, a una relazione simbolica del gruppo con sé stesso e con una ricostruzione continua della memoria stessa.
Da allora, l’indagine sul rapporto tra memoria e identità è divenuta un elemento centrale sia nella riflessione teorica sia nelle elaborazioni politiche. Non è un caso che l’autore di una teoria sulla memoria collettiva sia stato ucciso da un potere che sulla deformazione di quella memoria ha fondato tutta la sua costruzione ideologica.
Il volume di Chiara Nencioni, A forza di essere vento. La persecuzione di rom e sinti nell’Italia fascista (prefazione di Luca Bravi, postfazione di Noell Maggini, edizioni Ets, Collana Verba manent, pp. 208, euro 18), si pone proprio dentro questa disamina permanente sulla riflessione tra storia e memorie perché incrocia le tracce di un’oralità a rischio e i documenti d’archivio per indagare il Porrajmos italiano, ovvero la persecuzione di rom e sinti da parte del regime fascista, la sua relazione con la Shoah e le ragioni di una lunga rimozione da parte della storiografia ufficiale.
Chiara Nencioni – docente di lettere, dottoranda di storia nell’ateneo di Pisa, membro del comitato scientifico del corso di perfezionamento in didattica della Shoah dell’Università di Firenze – al Porrajmos (grande divoramento) preferisce il termine Samudaripen (sterminio di tutti, ovvero genocidio) perché rende meglio l’equivalenza e la simultaneità con la Shoah ebraica. Stessi campi, stesse modalità. Ma lo sterminio di sinti, rom e manouches – mezzo milione di persone uccise, un quarto della popolazione presente in Europa tra le due guerre – è stato sostanzialmente trascurato, se non negato, dalla gran parte degli addetti ai lavori e dalle istituzioni.
Solo nel 2009, il 16 dicembre, in occasione del 71° anniversario della promulgazione delle leggi razziali, la Camera dei deputati ha citato la persecuzione di rom e sinti. Il Samudaripen non è nemmeno citato nella legge 177 del luglio 2000, quella che istituisce la Giornata della memoria. Eppure già nel 1965, Paolo VI incontrò rom e sinti a Pomezia e alcuni di essi gli mostrarono la matricola di Auschwitz tatuata sull’avambraccio. Se la Germania riconobbe quella gente come vittima dei nazisti nei primi anni Ottanta, l’Italia era solo preoccupata di ghettizzarla nei campi nomadi.
Per molto tempo le versioni ufficiali hanno costruito e intrecciato due alibi per giustificare il silenzio: da un lato la presunta mancanza di interesse dei rom, considerati incapaci di narrazione storica, dall’altro quello del «cattivo tedesco» contrapposto al falso mito degli «italiani brava gente» con cui si è rimosso per lunghi decenni il curriculum criminale del colonialismo nostrano e il passato fascista.
Il volume smonta entrambe le versioni di comodo per restituire tutto lo spessore di fonti orali e scritte di rom e sinti mettendo a nudo il succedersi di due elementi determinanti prima per il Porrajmos italiano, poi per la sua rimozione: da un lato un antitziganismo che il Ventennio eredita dal Regno d’Italia per radicalizzarlo fino alla deportazione, dall’altro la mancata defascistizzazione – lo spiega bene Luca Bravi nell’introduzione – degli apparati burocratici, polizieschi, giudiziari e accademici che ha reso possibili la mancata decostruzione degli stereotipi discriminatori contro rom e sinti e le politiche pubbliche che, tenendo a distanza i «nomadi», hanno emarginato anche la loro memoria collettiva, spingendo le persone a esporre la memoria solo in contesti di rispetto, ossia nella dimensione familiare o comunitaria.
Il libro non smonta solo gli alibi della storiografia restituendo lo spessore dei racconti lungo i decenni, ma scoperchia le radici di un antitziganismo che ha finito per influenzare anche l’approccio di chi – come un settore di cattolicesimo progressista- ha creduto di agire nell’interesse di rom e sinti.
Checchino Antonini, il manifesto, 27 marzo 2024