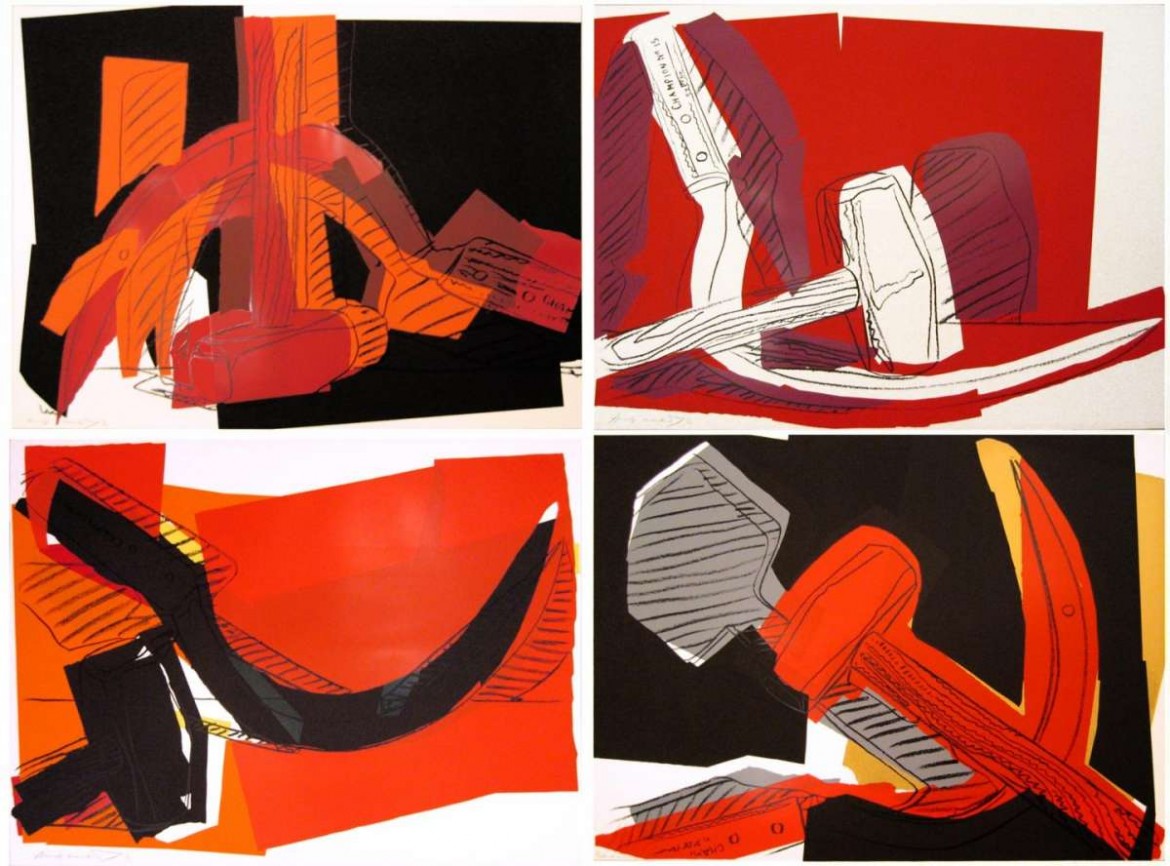 La “sinistra” sembra non accorgersi che la questione centrale sia più che mai il lavoro, non semplicemente in termini di occupazione, ma di forme, qualità e tempi di lavoro.
La “sinistra” sembra non accorgersi che la questione centrale sia più che mai il lavoro, non semplicemente in termini di occupazione, ma di forme, qualità e tempi di lavoro.
Nemmeno la “sinistra anticapitalista” (forse più attenta alla propria sopravvivenza che non alla costruzione di un’opposizione sociale) ha messo al centro del suo dibattito questo tema fondamentale per la costruzione di un’alternativa sociale, perché capace di aprire ad una ipotesi di società diversa.
Nel mondo occidentale è il tema che fa i conti con le forme assunte dal lavoro: precario, flessibile e tecnologico.
Mentre il lavoro di produzione taylorista è sempre più relegato, e in aumento, nel resto del mondo, in occidente il lavoro ha assunto forme che ci obbligano a rileggere le dinamiche sociali e riscrivere anche le forme della “lotta di classe”.
E’ in queste condizioni che il lavoro diventa la leva formidabile per parlare di organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero, di uso e controllo delle tecnologie nel lavoro e oltre, di nuove forme di salario e di reddito, di qualità della vita..
Così temi come la qualità del lavoro, la riduzione del tempo di lavoro e l’introduzione del “reddito di base universale” potrebbero diventare le colonne portanti di una “lotta di classe” possibile, non solo qui ma in tutto il mondo.
Sarebbe così possibile coniugare la liberazione del lavoro con la liberazione dal lavoro!
Un articolo di Andrea Aimar apparso sul numero di ottobre de L’indice dei libri del mese ci guida in questo dibattito e ci offre una bibliografia critica intorno a questi argomenti.
Caporalato digitale e “folla lavoro”. Il dibattito su lavoro, reddito e salario nell’era delle piattaforme
Andrea Aimar*
La traduzione letterale del termine gig rimanda al veicolo trainato da cavalli: quest’ultimo era il mezzo con cui gli artisti (jazz band in particolare) si muovevano negli anni della grande crisi americana per giungere al locale della prossima esibizione. La prestazione era per sua natura occasionale e liquidata al termine del concerto. E poi di nuovo in strada, briglia sciolta alla volta del prossimo luogo di lavoro.
Ancora le professioni culturali e artistiche hanno conservato, nonostante lo scorrere dei decenni, lo stigma del “quasi lavoro”, dell’hobby più che del mestiere, del piacere che non può diventare occupazione. E un caso se oggi per definire la cosiddetta “economia dei lavoretti” utilizziamo il termine gig economy che porta con sé quelle radici ?
In Italia abbiamo imparato a conoscere i fattorini delle consegne di cibo e per un breve periodo gli autisti-non tassisti di Uber. Meno conosciute alle nostre latitudini le piattaforme di “lavoretti” come Mechanical Turk, Upwork, Handy o Taskrabbit: ti iscrivi elencando cosa sai fare e dall’altra parte qualche datore di lavoro ti commissiona un compito da portare a termine in breve tempo. Funzionano come delle grandi agenzie di collocamento, domanda e offerta si incontrano virtualmente. Di norma le retribuzioni non sono un granché e, in alcuni casi, come per Mechanical Turk (di proprietà di Amazon), se il committente non ritiene il lavoro adeguato può decidere di non pagare.
Alla base c’è la rete e l’approccio inaugurato dai social networks, grazie ai quali le piattaforme rappresentano dei luoghi di scambio e di nuova intermediazione. Sono delle piazze dove chi ha un’auto, una casa, una competenza le mette a disposizione di chi, pagando, intende usufruirne. La retorica alla base di queste esperienze fa perno su un’idea di condivisione (sharing economy). La maggior parte della casistica, e le esperienze di maggior successo, vanno però iscritte nella categoria del cosiddetto capitalismo di piattaforma che spesso si traduce, più che in celebrazioni della condivisione, in risparmio i costi (tendenzialmente a danno del lavoro). Da un lato chi consuma è contento, nonché ha necessità, di spendere meno per beni e servizi, dall’altro chi lavora è disposto a fare di tutto e a qualunque condizione per arrivare alla fine del mese. Nel mezzo, loro: i proprietari delle piattaforme che hanno progettato le nuove piazze, ricevendone soprattutto gli onori sotto forma di transazioni e pochi oneri non dovendo contrattualizzare chi lavora per loro, pagare le tasse e i contributi.
Da questa angolazione prende il via il libro-inchiesta di Riccardo Staglianò, Lavoretti (Einaudi, 2018), che oltre a raccontare alcune storie di “utenti” e “collaboratori” delle piattaforme (perché non ci contratto e non c’è rapporto di dipendenza formale), compie un a ritroso per comprendere come si è arrivati a queste forme di lavoro.
Mette insieme tre date: 1979, 2000, 2008. Sono cesure simboliche, utili per un excursus sul processo di finanziarizzazione, sulla globalizzazione e la deregolamentazione dei mercati, la bolla delle dor com e l’attuale crisi economica dai caratteri strutturali. Secondo Staglianò oggi non racconteremmo di lavoretti, non parleremmo del successo di Uber o di “turchi meccanici” senza quella lunga stagione di aumento delle disuguaglianze, di indebolimento del mondo del lavoro e dei sindacati. C’è anche, ovviamente, il portato dell’innovazione e dell’automazione a raccontare il mutamento dei rapporti di forza. Riecheggiano i temi del precedente libro di Staglianò, Al posto (Einaudi, 2016), dove aveva affrontato il problema della riduzione del lavoro disponibile.
Ci sono le app, gli schermi di un pc e gli smartphone, ma sembra di essere tornati a fine Ottocento. Dietro la retorica dell’imprenditore di se stesso e del lavoro autonomo emergono i tratti di un caporalato digitale. È difficile non pensare all’intermediazione di manodopera senza diritti amministrata dai caporali. Se stiamo alla metafora della piazza, su piattaforme come Mechanical Turk si ripropongono le dinamiche di una chiamata al lavoro di quel tipo: masse di persone bisognose in attesa di qualcuno che li scelga, disposte ad accettare qualsiasi condizione in un rapporto senza più i caratteri di compromesso del capitalismo industriale. Della fabbrica sembra rimanere una organizzazione del lavoro scientifica la Taylor: si eredita una profonda divisione dei compiti e una netta separazione tra progettazione ed esecuzione. Non ci più un ufficio, tempi e metodi, non c’è un cronometrista a misurare le operazioni, ma un comando impersonale come quello degli algoritmi.
Benedetto Vecchi nel suo Il capitalismo delle piattaforme (manifestolibri, 2017) riflette su questa nuova organizzazione della “folla lavoro”. Vecchi propende per sconsigliare l’uso del termine taylorismo, in quanto manca, rispetto all’organizzazione scientifica, un preciso decalogo di mansioni e movimenti da compiere (“one best way”). Esistono “tempi contratti di esecuzione”, ma all’input della piattaforma segue l’organizzazione e la gestione dei compiti che è totalmente delegata al lavoratore. Per Vecchi, piuttosto, ritornano i caratteri di un lavoro servile circoscritto al rapporto individuale tra singolo e piattaforma digitale.
Su questa condizione di un lavoro fintamente autonomo, ma anche sul suo potenziale liberatorio, riflette anche l’ultimo libro di Roberto Ciccarelli, Forza lavoro (DeriveApprodi, 2018), Oltre a ritrovare, come in Staglianò, un affresco sul lavoro nelle piattaforme, il volume del giornalista de il manifesto ricostruisce da un lato una genealogia del lavoro autonomo molto stimolante e dall’altro compie una ricognizione sul concetto di forza lavoro di derivazione marxiana. C’è, come anche in Vecchi, il richiamo alla messa al lavoro dell’intera esistenza umana che il capitalismo digitale pretende. Così come emergono i termini della cooperazione sociale, che al momento le piattaforme riescono a catturare e valorizzare nei loro modelli organizzativi. Proprio l’elemento della cooperazione, così come l’ininterrotta ricerca di autonomia, starebbero alla base di un possibile processo di consapevolezza da parte della forza lavoro per autodeterminarsi e recuperare protagonismo all’interno di un disegno emancipatorio. Il reddito di base e le riduzione dell’orario sono gli strumenti politici nella disponibilità della forza lavoro per recuperare autonomia.
Il capitalismo digitale e l’impatto dell’innovazione, così come si delinea in Vecchi e Ciccarelli (con qualche distinguo in Staglianò), rende attuali le riflessioni anti-lavoriste e sull’uso potenzialmente liberatorio della tecnologia di un pensatore eretico ed eclettico come “Bifo“, al secolo Franco Berardi. DeriveApprodi ha dato alle stampe un’antologia del teorico bolognese dal titolo inequivocabile Quarant’anni contro il lavoro. Gli scritti, soprattutto quelli del decennio ottanta (così come gli ultimi), nel nuovo scenario paiono anticipatori soprattutto sul tema del rapporto lavoro-tecnologia e del mutamento antropologico imposto dalle nuove forme di comunicazione. Così come torna la crisi della società salariale, anche se nell’auspicio di Bifo doveva rappresentare un’uscita volontaria di liberazione dal lavoro. Oggi quella crisi non racconta il superamento del lavoro salariato ma, proprio nella plastica rappresentazione del capitalismo delle piattaforme, la cancellazione delle norme e dei compromessi che lo avevano forgiato nel secolo scorso.
La proposta di reddito di base sganciata dal lavoro è nelle corde sia di Vecchi che di Ciccarelli mentre trova più tiepido, seppur non ostile, Staglianò. Quest’ultimo, in un ripetuto tributo ai lavori di Luciano Gallino. richiama la politica alle proprie responsabilità, sia per le scelte del passato che per la necessità di adottare oggi delle soluzioni. Il richiamo è in particolare a forme di regolazione
Dell’attività delle piattaforme e soprattutto a una Stretta sulla questione dell’elusione fiscale di questi soggetti multinazionali.
Il tema che campeggia spesso nei dibattiti sul lavoro nell’era digitale è la questione della contendibilità delle tecnologie. Perché quelle stesse piattaforme, quei codici diversamente programmati, non possono essere strumenti per immaginare migliori organizzazioni del lavoro?
In questo solco muove l’ipotesi del “platform cooperativism” promossa da Trebor Scholz (OR Books, 2016) e il “proetto zero” delineato in conclusione di Post capitalismo (il Saggiatore), da Paul Mason. L’invito è di utilizzare e sfruttare il potenziale emancipatorio delle nuove tecnologie per lavorare meno e meglio. Sono proposte evocative che seguono una logica volontarista, ma pare mancare in queste letture una dimensione politica di conflitto tra interessi contrapposti.
Nick Srnicek e Alex Williatns nel loro Inventare il futuro (Nero Editions, 2018) vanno oltre, abbracciando direttamente la prospettiva cosiddetta “accelerazionista”: in quest’ottica un progetto di liberazione non può passare che dallo spingere all’estremo il potenziale dello sviluppo tecnologico. Sullo sfondo c’è sempre il tema della riduzione del tempo di lavoro, del reddito di base universale e della capacità di saper organizzare diversamente la produzione. Ritorna il Bifo che invita a “resistere alla mutazione” e ad abbracciarla per far transitare l’umanità verso nuovi scenari di libertà. La contesa è aperta: chi è disposto a immaginare il futuro senza più nostalgie ?
L’Indice dei libri del mese, ottobre 2018,
*A. Aimar, giornalista free lance
aimar.andrea@hotmail.it

L’introduzione all’articolo mi ha incuriosito ed indotto a leggerlo: vuoi vedere che finalmente qualcuno della sinistra si sta svegliando?….Invece alla fine ho trovato un mero elenco di gente che scrive “cosa si dovrebbe fare”, invece di proporre come farlo…e subito! Il solito , ormai annoso problema della sinistra: troppe parole e pochissimi fatti. Ormai è tempo di fare, fare, fare. Grazie per l’accoglienza. Eraldo Zegna
Hai ragione Eraldo. Ma i tempi del “fare” sono oggi tanto urgenti quanto lunghi, molto lunghi. Forse, se la sinistra si dedicasse rigorosamente all’analisi e alla riflessione, invece di impegnarsi alla costruzione del “partito”, potrebbe trovare le ragioni per cominciare ad agire ora!
Ciao, Marco